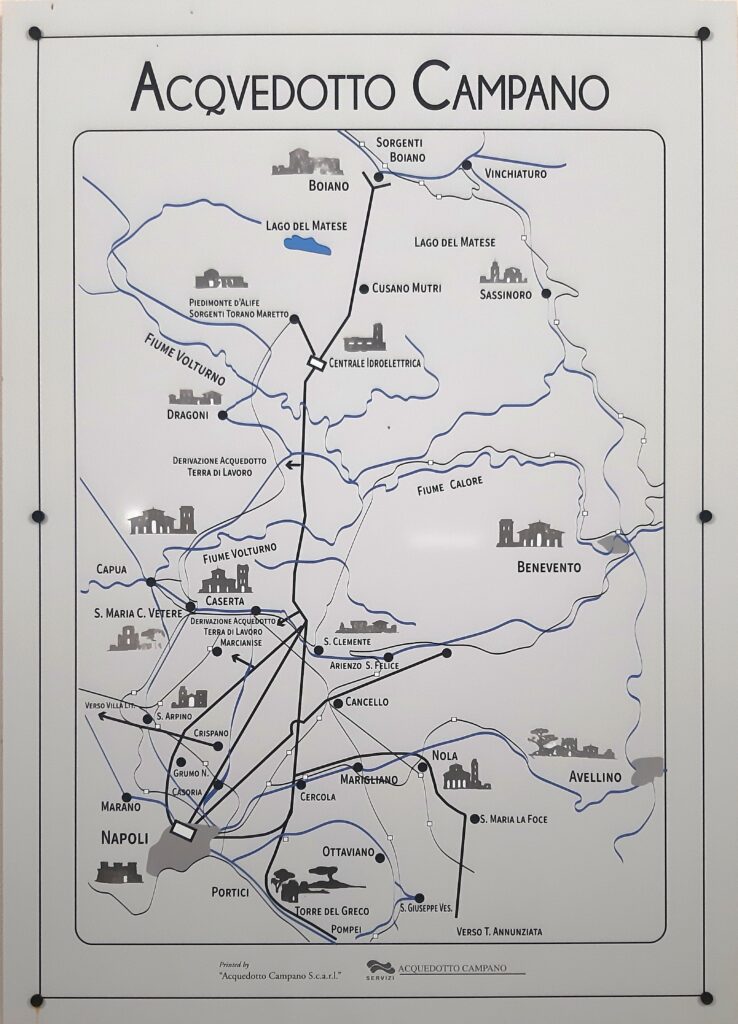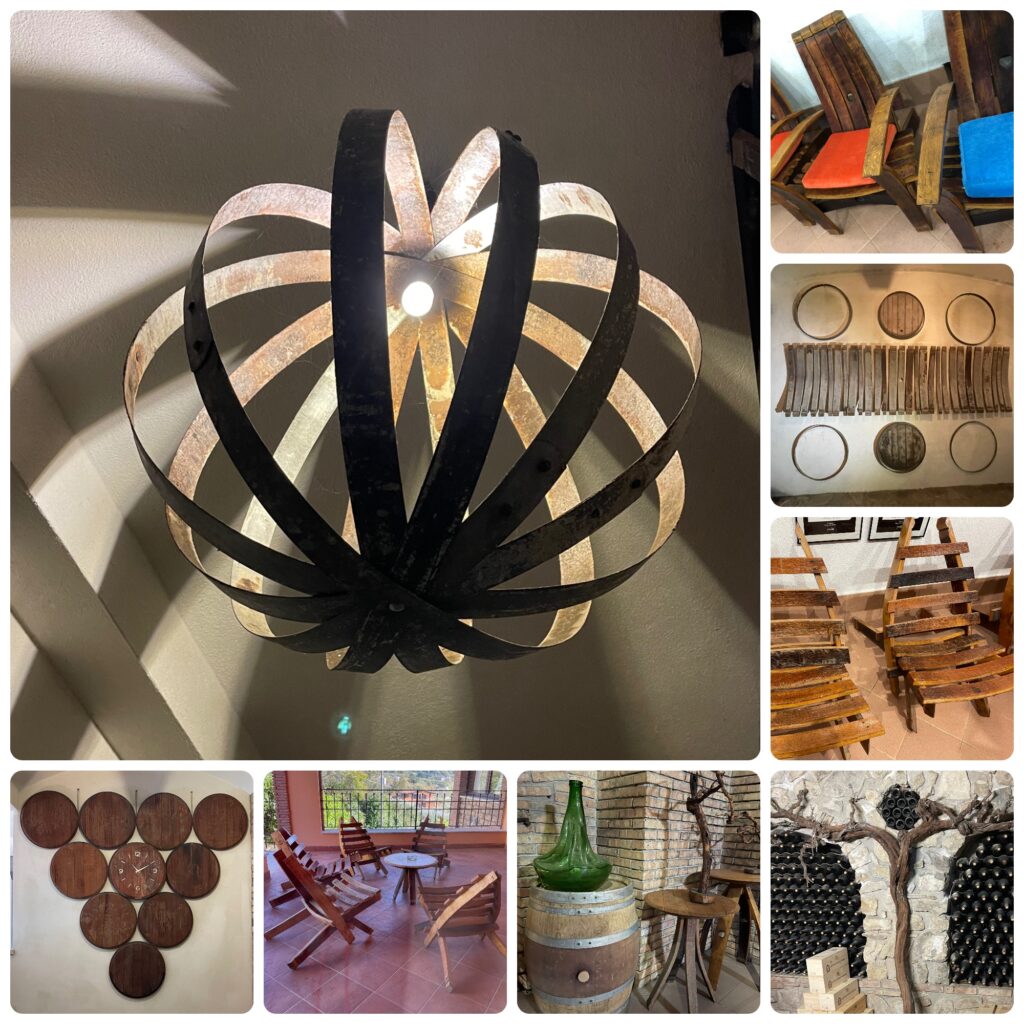Dieci impeccabili ambasciatori di un territorio ricco di fascino e di grandi potenzialità; dieci calici vibranti, ghiotti e appaganti, da bere tutti i giorni e perfetti per le occasioni speciali. Senza eccezione alcuna, si sono abbinati alla perfezione con gli squisiti piatti che l’Osteria Poerio ha preparato per l’occasione.
La Città Eterna accoglie con entusiasmo il “Morellino del Cuore” on tour, e lo fa in grande stile ospitando stampa e produttori nella deliziosa cornice dell’Osteria Poerio a Monteverde Vecchio, uno dei quartieri più signorili di Roma. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Consorzio di Tutela Morellino di Scansano DOCG e i giornalisti Antonio Stelli e Roberta Perna, offre un’opportunità unica per esplorare l’evoluzione di un vino che affonda le sue profonde radici nella luce e nella tradizione della rigogliosa terra di Maremma.

Morellino del Cuore: la Maremma tra passato, presente e futuro
La prima edizione, nel maggio dello scorso anno, ha coinvolto sei esperti giurati, capitanati dalla giornalista Stefania Vinciguerra, Caporedattore di DoctorWine, in una degustazione alla cieca di 64 etichette per 36 produttori. È così che sono stati selezionati i 10 vini ambasciatori della DOCG, in grado di riportare nel calice tutta l’essenza e la emozionante suggestione del territorio.
La costa maremmana è originariamente una terra di tradizioni rurali in cui il Sangiovese, vitigno continentale, non deteneva inizialmente un ruolo predominante. In passato, la produzione di vino in questa zona era orientata principalmente al consumo immediato, senza una chiara identità di stile, né tantomeno la necessità di produrre vini destinati all’invecchiamento.
Tuttavia, la straordinaria versatilità e la capacità di adattamento del Sangiovese al microclima marino della Maremma hanno portato a una trasformazione significativa della base ampelografica del territorio. Il Sangiovese ha saputo conquistare spazio tra gli altri vitigni, plasmando il carattere distintivo del Morellino di Scansano.
Identità, sinergia e qualità costituiscono oggi i pilastri fondamentali su cui basare l’ascesa verso l’eccellenza della Denominazione. La DOCG, relativamente piccola e frammentata in tanti produttori, sta lavorando in sinergia per consolidare la sua riconoscibilità distintiva attorno al Sangiovese del mare, impegnandosi altresì ad elevare costantemente l’asticella della qualità con l’obiettivo di distinguersi come Denominazione di prestigio della Toscana.
Nuove chiavi di lettura per una comunicazione sempre più efficace
L’originale classificazione di “Morellino del Cuore”, che suddivide le etichette in tre categorie – Annata, Intermedia e Riserva – non coincide perfettamente con quella del Consorzio che attualmente distingue solo tra vini d’Annata e Riserva. Eccole svelate dunque le 10 etichette del cuore, rigorosamente in ordine di apparizione.

Per il Morellino Annata conquistano il cuore della critica specializzata:
- Santa Lucia – Morellino di Scansano Docg A’ Luciano 2022
- Tenuta Agostinetto – Morellino di Scansano Docg La Madonnina 2022
- Mantellassi – Morellino di Scansano Docg Mago di O3 2022
- Le Rogaie – Morellino di Scansano Docg Forteto 2021
Per la categoria Intermedia sul podio del cuore troviamo:
- Boschetto di Montiano – Morellino di Scansano Docg Io&Te 2021
- Cantina Vignaioli di Scansano – Morellino di Scansano Docg Vigna Benefizio 2021
- Podere 414 – Morellino di Scansano Docg 2020
Le Riserva da batticuore sono invece:
- Roccapesta – Morellino di Scansano Docg Roccapesta Riserva 2020
- Morisfarms – Morellino di Scansano Docg Riserva 2019
- Terenzi – Morellino di Scansano Docg Riserva Madrechiesa 2019
Il nostro cuore batte forte per tutti, ma se fossimo obbligati a sceglierne solo uno per categoria sul nostro podio personale trovereste loro.

Le Rogaie – Morellino di Scansano Docg Forteto 2021
Una realtà giovane ma con le idee già molto chiare, la famiglia Poggi esordisce nel 2019, e due anni dopo tira fuori un vero gioiello. Un Sangiovese in purezza da vigne vecchie che convince col suo sorso scorrevole e dinamico, tannini decisi ma garbati, e una corroborante carica balsamica in cui il profumo della brezza marina si fonde e confonde con sentori di macchia mediterranea. Lunghissima persistenza sapida.
Cantina Vignaioli di Scansano – Morellino di Scansano Docg Vigna Benefizio 2021
Con 170 soci e circa 700 ettari vitati che si estendono dal mare fino alle pendici del Monte Amiata, la Cantina, fondata nel 1972, ha di fatto scritto un copioso e importante capitolo nella storia del Morellino di Scansano. Sangiovese in purezza, sapido e carnoso, scorrevole ed equilibrato, e con un bouquet profondo e sfaccettato, il Vigna Benefizio forse incarna più di altri l’emblema di quel vino di mare attorno al quale consolidare l’identità e la riconoscibilità della Denominazione.
Roccapesta – Morellino di Scansano Docg Roccapesta Riserva 2020
Con 35 cloni su 30 ettari vitati, da Alberto Tanzi non troverete altro che Sangiovese. Espressivo ed elegante come si addice ai purosangue di alto lignaggio, ammalia con un bouquet complesso e raffinato, e avvolge in un caldo abbraccio con tannini levigati e una scia sapida interminabile. Ha tutte le carte in regola per un lungo invecchiamento.

La tecnologia innovativa Purovino® per un vino senza solfini aggiunti
Menzione speciale per il Mago di O3 2022, il primo Morellino di Scansano senza solfiti aggiunti, prodotto dalla cantina Mantellassi con la tecnologia innovativa Purovino®. La saturazione della camera di stoccaggio con Ozono sterilizza le uve, che sono poi lavorate con attrezzature trattate con lo stesso gas. Il mosto così non ha bisogno di SO2, né tanto meno sarà necessario aggiungere solfiti al vino per preservarne nel tempo le proprietà organolettiche e la salubrità.
Vi lasciamo con una riflessione: sarà solo una coincidenza, ma i più convincenti sono stati i vini da Sangiovese in purezza, forse anche questo un dettaglio da capitalizzare nella definizione di una identità forte.