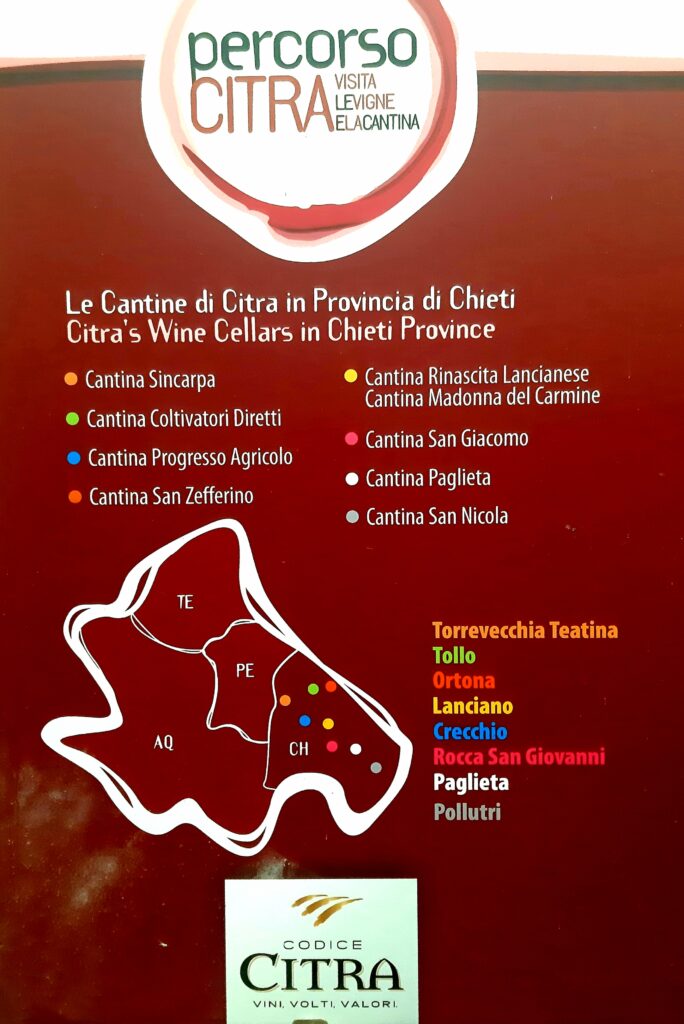Il nostro viaggio nel meraviglioso mondo dei vini d’Italia fa oggi tappa tra le vigne della Doc Colli di Luni, nella provincia di La Spezia, in quella pianura che dal sud del fiume Magra arriva alle pendici delle Alpi Apuane, ultimo lembo della Liguria di levante, al confine con la Toscana. Qui negli anni sessanta nasce la Cantina Lunae grazie alla passione, al talento e alla lungimiranza di Paolo Bosoni che ha trasformato una piccola realtà produttiva familiare, tre ettari destinati alla produzione di vino sfuso, in un’azienda enologica di forte impatto qualitativo e produttivo e con una imponente e incisiva presenza sul territorio.
La DOC Colli di Luni, attiva dal 1989, è uno dei risultati arrivati dall’audacia e dalla tenacia del patron Bosoni, che ha saputo guidare con coraggio e valore tutti i produttori della zona facendosi portavoce di un territorio, interpretandolo, sperimentando e aprendosi al futuro. La collaborazione con i piccoli vignaioli locali che conferiscono le loro produzioni (nei 20 ettari circa di vigneti) all’azienda Bosoni, da tre generazioni, ha creato una rete sociale, un percorso in continuo sviluppo, mantenendo vive le tradizioni e le qualità uniche della viticoltura del territorio. Una storia con radici antiche, un terroir già caro agli Etruschi che seppero individuare queste fertili terre come un luogo straordinario per produrre uva.
Le Alpi Apuane e le montagne proteggono dai venti freddi del nord, il mare regala una buona ventilazione e una notevole escursione termica, i suoli, di medio impasto e ricchi di scheletro nelle zone collinari e pedecollinari, limo-argillosi nelle aree pianeggianti, consentono di produrre vini con profili completamente differenti.

Il Vermentino, varietà principe della zona e della famiglia Bosoni, ha attecchito in perfetta simbiosi con le condizioni pedoclimatiche del luogo: quote altimetriche diverse, suoli variegati, brezza marina che determinano le sue numerose sfaccettature. Al suo fianco, negli 85 ettari totali dell’azienda, altri vitigni autoctoni come Albarola, Vermentino Nero, Malvasia, Pollera Nera e Massareta, impiantati e resi degni della stessa storia.

Stessa passione di un tempo, ma con uno sguardo volto alla modernità. I due figli di Paolo, Diego e Debora, che lavorano a stretto contatto con il padre, hanno raggiunto ormai risultati tangibili in ogni prodotto apprezzato dalla critica e dal pubblico di consumatori. C’è tutto questo in “Bosoni & Figli” anche nella nuova cantina LVNAE, inaugurata lo scorso giugno: moderna, bella, accogliente e e rispettosa della tradizione e della sostenibilità grazie alla scelta mirata dei materiali. Un percorso a piedi all’ingresso attraversa i principali vitigni autoctoni dei Colli di Luni e ne testimonia i punti cardini dell’azienda: tradizione e territorio.

Ca’ Lunae, invece, a Castelnuovo Magra, è un antico casale del Settecento completamente ristrutturato nel rispetto delle forme e delle materie, dove si accolgono i visitatori e si permette loro di sperimentare il territorio.

Ad arricchire il luogo due laboratori per la produzione di liquori con ben 12 tipologie diverse, stagionali, entusiasmanti e uniche nel loro genere, ed un autentico Museo del Vino.

Una raccolta di antichi oggetti agricoli conservati da Paolo Bosoni, diventata, all’interno della vecchia casa padronale, un percorso evocativo nel mondo contadino della Lunigiana storica, arricchito e curato da esperti e testimoni dell’epoca.

La visita e la degustazione testimoniano la cura e l’attenzione che Paolo e la sua grande famiglia (includendo amici e dipendenti) hanno nel gestire l’azienda. Nulla è lasciato al caso: vini semplicemente straordinari con forti personalità ed elevata qualità.
Valentina, la nostra guida nel mondo di Lunae, ha previsto per noi una verticale nel mondo Vermentino. L’idea è quella di illustrare un percorso crescente nel mondo del vitigno tanto caro a Paolo Bosoni ed alla sua famiglia.

LaBianca 2022 – Liguria di Levante I.G.T. Bianco – 12,5%
Nasce da uve Vermentino con l’aggiunta di Malvasia in vigneti situati nella piana di Luni, tra il Mar Ligure e le Alpi Apuane, radicati su terreni di natura sabbiosa. Fermentazione a temperatura controllata in acciaio, affinamento sulle fecce fini per circa 4 mesi
Il LaBianca di Lunae si offre allo sguardo di un colore giallo paglierino intenso. Al naso sprigiona profumi di frutta a polpa gialla, macchia mediterranea e pietra focaia. Il sorso è di vibrante freschezza e mineralità. Sul finale cenni fruttati e di erbe aromatiche.

Etichetta Grigia 2022 – Colli di Luni d.o.c. Vermentino – 12.5 % vol.
Emblema ed icona della cantina, è il primo vino realizzato dalla vinificazione di uve Vermentino da Paolo Bosoni, più di quarant’anni fa. Il Vermentino proviene per la totalità dai vigneti delle zone pedecollinari di Luni, Castelnuovo Magra e Sarzana. Oggi, come allora, segue lo stesso percorso: raccolta manuale, fermentazione a temperatura controllata in acciaio, affinamento sulle fecce fini in acciaio per circa 3 mesi.
Nel bicchiere appare giallo paglierino con sfumature verdoline. Profumo intenso, complesso e persistente con note di biancospino, pompelmo, mela renetta, pesca bianca e piacevole sottofondo di miele dacacia. In bocca si presenta fresco, equilibrato, di ottima persistenza.

Etichetta Nera 2022 – Colli di Luni d.o.c. Vermentino – 13% vol.
Prodotto dal 1992, frutto di un lungo periodo di sperimentazione ed esperienze in campo e in cantina per testimoniare le grandi potenzialità che questo vitigno riesce ad esprimere. Uve prodotte nelle Colline di Luni e Castelnuovo Magra, raccolte a mano e macerate a freddo sulle bucce per circa 8 ore fermentazione a temperatura controllata in acciaio, affinamento sulle fecce fini in acciaio per circa 4 mesi.
Nel calice si manifesta dotato di grande stoffa, carattere e fascino, caratterizzato da un colore giallo paglierino intenso, con leggeri riflessi dorati. Al naso si fa notare per la sua grande eleganza, con sentori di fiori di campo, erbe aromatiche, spezie, frutta matura e miele, accompagnate da note salmastre e balsamiche. In bocca, invece, si rivela per la sua sapidità, assolutamente bilanciato e soprattutto molto persistente. La sua importante verticalità in freschezza le renderà capace di sorprendere anche nel tempo.

Cavagino 2022 – Colli di Luni D.O.C. Vermentino – 14 % vol.
Il primo Cru di Vermentino della casa e del territorio. Nasce da una vigna singola con basse rese, posta sulle colline di Luni (a 250 metri di altitudine), dove microclima equilibrato e suolo ricco di scheletro con una buona presenza di macigno la fanno da padroni. Macerazione a freddo sulle bucce per circa 12 ore, fermentazione a temperatura controllata in acciaio per il 60 % della massa totale, fermentazione in barriques per la restante parte del mosto. Affinamento sulle fecce fini in vasca d’acciaio per circa 6 mesi.
Si evidenzia alla vista di un colore giallo paglierino di grande vitalità con riflessi dorati. All’olfatto regala note di frutta matura, mela e pera, papaja, e poi pietra bagnata, spezie, erbe balsamiche e miele di acacia, combinati a cenni di fiori bianchi e scorza d’agrumi. Il sorso è pieno e vigoroso, di grande struttura con note calde, morbide e un equilibrio legato alla spiccata mineralità che gli conferisce sapidità e bevibilità. Lungo e avvolgente il finale balsamico e agrumato, con una piacevole nota salmastra.

Numero Chiuso 2020 – Colli di Luni d.o.c. Vermentino – 14 % vol.
Il Vermentino più strutturato ed importante della Cantina Lunae, di diritto tra le migliori etichette della produzione nazionale. Nasce dalle osservazioni di quanto l’affinamento del vermentino in purezza, in alcune annate, apporti in termini di profondità e complessità: un vino capace di esprimersi negli anni.
Le uve vengono selezionate in due vigne storiche delle Colline di Luni e Castelnuovo Magra. Macerazione a freddo sulle bucce per circa 12 ore, fermentazione a temperatura controllata in vasca d’acciaio, affinamento in botte di rovere da 20 ettolitri per circa 18 mesi. Dopo l’imbottigliamento ulteriore affinamento in bottiglia per 18 mesi.
Colore giallo dorato tenue, con intensi riflessi brillanti, è visibile nel bicchiere. Olfatto elegante, accompagna la degustazione con intensi profumi di frutta, fiori gialli, erbe aromatiche della macchia mediterranea, cenni tropicali su un sottofondo iodato, burro e vaniglia. Al palato diventa appagante, ricco, intensamente strutturato. Freschezza e salinità anticipano un persistente finale di frutta secca, elegante e armonico.

Termino questo ricco ed emozionante racconto, con l’ultima chicca.
Padre Figlio – Limited edition 2019 – Vino Bianco – 13,0 % vol.
A continuare l’estro enologico di Paolo in vigna e in cantina è il figlio Diego Bosoni con le sue produzioni. La firma personale per l’etichetta Padre Figlio è il racconto perfetto ed emozionante di un rapporto complesso, quello tra un padre ed un figlio. La stessa immagine sull’etichetta ricorda due visi diversi fusi in una sola faccia con capelli arruffati per la genialità di chi li governa. Due generazioni a confronto che si affidano in bottiglia al Vermentino, nelle sue vesti di figlio del territorio ma vitigno capostipite tra gli autoctoni della zona, coltivato su suoli antichissimi, complessi, difficili per la vite.
Selezione dei migliori grappoli nelle prime ore del mattino, da un solo vigneto nell’antico borgo di Castelnuovo Magra, nel loro massimo punto di equilibrio tra dolcezza e acidità. Uve diraspate delicatamente, pressate e lasciate poi a riposo a contatto con il mosto per innescare la fermentazione spontanea. Affinamento di un anno in botte di rovere da 30 hl per levigare i tannini estratti dalle bucce e successivi 12 mesi in vasca d’acciaio. Tecniche antiche con attenzioni contemporanee.
Colore giallo con riflessi dorati. Profumi intensi di macchia mediterranea, resine e miele, albicocca matura, quasi candita. In bocca è ampio e avvolgente; caldo come l’abbraccio di un padre ma fresco, minerale e brioso con l’energia di un figlio giovane; ritornano nella retronasale le note percepite all’olfatto ben bilanciate da richiami balsamici. Un’armoniosa compresenza di Padre e figlio.

La filosofia di casa qui è di riscoprire e valorizzare vitigni autoctoni, accompagnandoli alle loro massime espressioni e portare avanti un lavoro che è fatto di rispetto per il territorio e qualità di relazioni umane. Il vino è frutto dell’armonia e della cooperazione fra natura e uomo e diventa parte fondamentale del suo carattere.